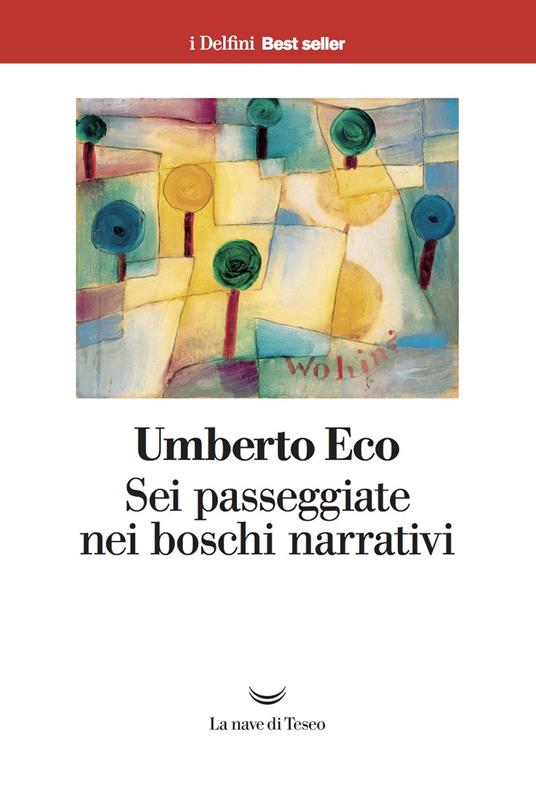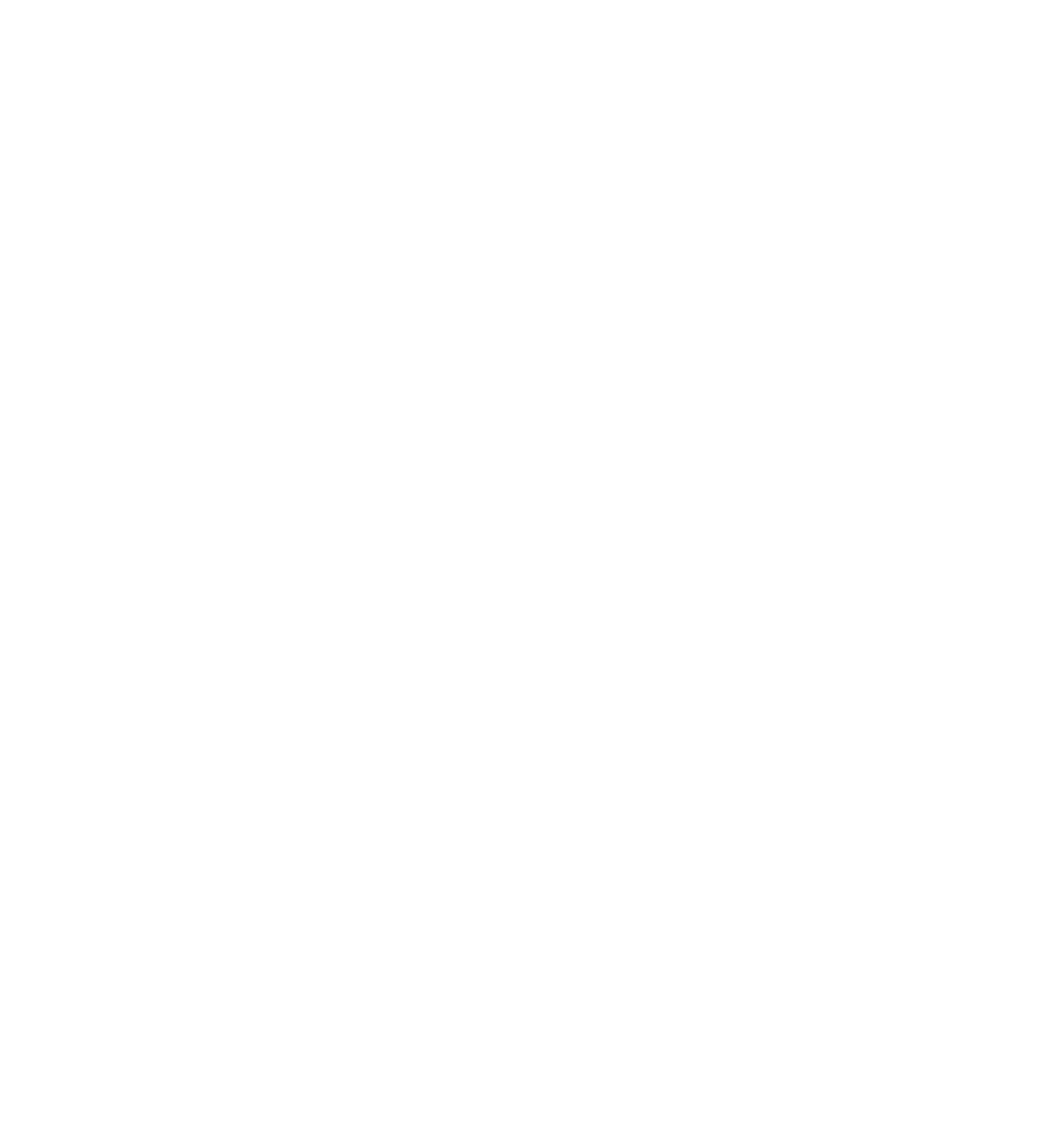Durante l’anno accademico 2024-25, i membri di Poetica e Cristianesimo hanno intrapreso una lettura approfondita di Sei passeggiate nei boschi narrativi di Umberto Eco (la raccolta delle Norton Lectures tenute all’Università di Harvard e originariamente pubblicate nel 1994 con il titolo Six Walks in the Fictional Woods).
Per Eco, il “bosco” è una metafora dei testi narrativi e le sue lezioni sono una riflessione estesa e spesso divertente sui diversi modi di leggere e rileggere i libri. La foresta narrativa può essere, ad esempio, un sentiero verso una destinazione particolare, l’oggetto stesso di uno studio analitico o semplicemente un luogo in cui vagare liberamente senza badare al tempo che passa.
Le passeggiate di Eco (ogni capitolo costituisce una passeggiata) traboccano di osservazioni su autori e libri di ogni genere: la letteratura italiana da Dante a Collodi, senza dimenticare Manzoni (la sua prospettiva narrativa ne I Promessi Sposi, secondo Eco, è in competizione con quella di Dio); Flaubert e Nerval (il suo straordinario senso del tempo nella novella Sylvie affascina Eco); Sant’Agostino; Edgar Allan Poe; Arthur Conan Doyle; Ian Fleming… perfino Edwin Abbot (l’autore ottocentesco di un bizzarro romanzo “geometrico” intitolato Flatlandia).
Lungo il percorso, le riflessioni ad ampio raggio di Eco hanno portato i partecipanti al seminario, ad affrontare questioni che toccano filosofia, narratologia, teologia, psicologia ed ermeneutica: la volontaria sospensione dell’incredulità; il complicato gioco di supposizioni e aspettative che autori e lettori formulano l’uno sull’altro; il peculiare tipo di verità di cui personaggi ed eventi di fantasia sembrano godere; la ricerca dell’autore ideale, che può essere o meno divino.
Alla fine, la stimolante discussione di questi sei capitoli su come leggere una storia sia una passeggiata nel bosco si è trasformata essa stessa in una passeggiata in un bosco discorsivo affascinante e provocatorio.